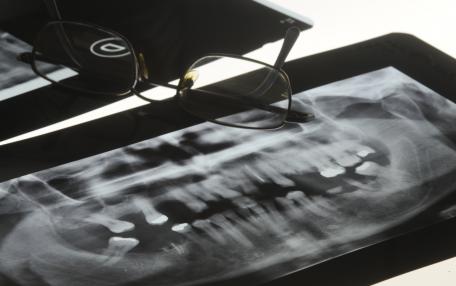Tracciato cefalometrico
Quando si valuta un caso di malocclusione non si deve pensare agli apparecchi di trattamento fino a quando il caso non è stato classificato e tutte le sue peculiarità e variazioni di normalità, occlusione e caratteristiche facciali non sono state completamente comprese. Quindi emergeranno il piano di trattamento e i requisiti appropriati. Quando si parla di tracciato cefalometrico si fa riferimento all’insieme delle procedure seguite per la misurazione della testa, la descrizione e quantificazione delle strutture coinvolte nella malocclusione (ossa, denti e tessuti). In sostanza il tracciato cefalometrico si realizza nello studio ortodontico e include la craniometria e la misura del viso. Il tracciato cefalometrico è una tecnica esplorativa strumentale che permette di analizzare la teleradiografia del cranio (laterofrontale) e di ottenere dati importanti per la diagnosi e il piano di trattamento delle malocclusioni.
Tracciato cefalometrico come si fa
I primi obiettivi nello sviluppo del tracciato cefalometrico sono stati lo studio della crescita del paziente e la definizione di standard che permettessero un confronto. La cefalometria ci permette davvero di avere una conoscenza della morfologia, fisiologia e patologia cranio-facciale e di poter individuare un iter terapeutico. Durante il trattamento, il tracciato cefalometrico serve per una valutazione dello stesso, del suo andamento e delle possibili modificazioni. Alla fine del trattamento, è un metodo importante per valutare la stabilità del risultato. La cefalometria dunque serve a caratterizzare l’anomalia dento-facciale, a confrontare alcuni problemi con altri così da differenziarli. In altre parole, il tracciato cefalometrico può fornire preziose informazioni sia al medico che al ricercatore e stabilisce le relazioni dimensionali delle componenti cranio-facciali. Non solo, il tracciato cefalometrico serve anche a classificare le anomalie scheletriche e dentali rispetto alla base cranica, al modello scheletrico, alle relazioni inter e intra dentali e al profilo dei tessuti molli. Inoltre il tracciato cefalometrico analizza la crescita e lo sviluppo responsabili del modello dentofacciale, nonché la configurazione della base cranica, anomalie congenite, condizioni patologiche o asimmetrie facciali. Inoltre serve a fornire il piano di trattamento per le procedure ortodontiche e/o chirurgiche e per analizzare i cambiamenti prodotti dal trattamento, l'efficacia delle diverse modalità di trattamento e l'efficacia della ritenzione.
Importanza della cefalometria radiografica
Tuttavia il tracciato cefalometrico non è una scienza esatta. I raggi X del cranio possono essere misurati con precisione, ma il margine di errore può variare ampiamente con ciascuno dei punti di riferimento. Le misurazioni effettuate nella teleradiografia possono avere errori di proiezione perché la radiografia della testa è un'immagine dimensionale di un oggetto tridimensionale e/o errori di posizione e punti cefalometrici da parte del medico. Uno dei fattori più importanti nell'analisi delle relazioni dentofacciali è la produzione di radiografie di alta qualità. I requisiti necessari affinché la radiografia sia utile prevedono che il paziente sia posizionato sul cefalostato con il piano di Frankfort parallelo al pavimento, che le labbra siano a riposo e che i denti siano in occlusione centrica e in relazione centrica. Non solo, il tracciato cefalometrico prevede anche che i tessuti molli e duri siano riprodotti sulla radiografia. I requisiti del medico che deve realizzare il tracciato cefalometrico sono una ottima conoscenza dell’anatomia, della fisiologia e della crescita cranio-facciale. Insomma, il tracciato cefalometrico è un grande aiuto per la diagnosi in ortodonzia anche se non lo è di più rispetto alla storia clinica e all’esame clinico.
Tracciato cefalometrico: un po' di storia
La cefalometria come metodo di studio e diagnosi ha quasi un secolo. L'introduzione della cefalometria radiografica fu effettuata da B. Holly Broadbent nel 1931, ma le indagini svolte a fini antropologici iniziarono nel 1780 da Camper che descrisse l'utilità dell'angolo formato dall'intersezione di un piano disegnato dalla base del naso al canale uditivo esterno (piano Camper) con il piano tangente al profilo facciale. Nel 1884, al Congresso Internazionale di Antropologia di Francoforte, il piano che collega il bordo superiore del canale uditivo esterno con il punto più basso del bordo orbitale fu accettato come piano di orientamento standard. Gli studi antropologici effettuati sui crani potrebbero essere approfonditi, a partire dal 1895, con la scoperta dei raggi X da parte di WK Von Rontgen. Nel 1921 AJ Pacini presentò la sua tesi "Antropotemetria radiografica del cranio", in cui viene discussa per la prima volta l'utilità di questo studio, per la conoscenza della crescita umana, della sua classificazione e delle sue anomalie. Stabilì che la precisione delle misurazioni ottenute dalla radiografia superava quelle fatte dalla comune antropologia. Ha trasferito alcuni punti antropologici convenzionali alla radiografia, come il gonion, il nasion e la spina nasale anteriore. Nel 1922 Atkinsons descrisse l'utilità della teleradiografia per determinare la posizione del primo molare superiore. Nel 1926, grazie all'entusiasmo dell'Onorevole Francis P. Bolton, fu condotto lo studio della normale crescita dei denti e delle mascelle dei bambini. Poi, nel 1932, grazie alla generosità della famiglia Bolton, si poté condurre uno studio longitudinale a lungo termine della crescita cranio-facciale.
Tracciato cefalometrico come si fa
I primi obiettivi nello sviluppo del tracciato cefalometrico sono stati lo studio della crescita del paziente e la definizione di standard che permettessero un confronto. La cefalometria ci permette davvero di avere una conoscenza della morfologia, fisiologia e patologia cranio-facciale e di poter individuare un iter terapeutico. Durante il trattamento, il tracciato cefalometrico serve per una valutazione dello stesso, del suo andamento e delle possibili modificazioni. Alla fine del trattamento, è un metodo importante per valutare la stabilità del risultato. La cefalometria dunque serve a caratterizzare l’anomalia dento-facciale, a confrontare alcuni problemi con altri così da differenziarli. In altre parole, il tracciato cefalometrico può fornire preziose informazioni sia al medico che al ricercatore e stabilisce le relazioni dimensionali delle componenti cranio-facciali. Non solo, il tracciato cefalometrico serve anche a classificare le anomalie scheletriche e dentali rispetto alla base cranica, al modello scheletrico, alle relazioni inter e intra dentali e al profilo dei tessuti molli. Inoltre il tracciato cefalometrico analizza la crescita e lo sviluppo responsabili del modello dentofacciale, nonché la configurazione della base cranica, anomalie congenite, condizioni patologiche o asimmetrie facciali. Inoltre serve a fornire il piano di trattamento per le procedure ortodontiche e/o chirurgiche e per analizzare i cambiamenti prodotti dal trattamento, l'efficacia delle diverse modalità di trattamento e l'efficacia della ritenzione.
Importanza della cefalometria radiografica
Tuttavia il tracciato cefalometrico non è una scienza esatta. I raggi X del cranio possono essere misurati con precisione, ma il margine di errore può variare ampiamente con ciascuno dei punti di riferimento. Le misurazioni effettuate nella teleradiografia possono avere errori di proiezione perché la radiografia della testa è un'immagine dimensionale di un oggetto tridimensionale e/o errori di posizione e punti cefalometrici da parte del medico. Uno dei fattori più importanti nell'analisi delle relazioni dentofacciali è la produzione di radiografie di alta qualità. I requisiti necessari affinché la radiografia sia utile prevedono che il paziente sia posizionato sul cefalostato con il piano di Frankfort parallelo al pavimento, che le labbra siano a riposo e che i denti siano in occlusione centrica e in relazione centrica. Non solo, il tracciato cefalometrico prevede anche che i tessuti molli e duri siano riprodotti sulla radiografia. I requisiti del medico che deve realizzare il tracciato cefalometrico sono una ottima conoscenza dell’anatomia, della fisiologia e della crescita cranio-facciale. Insomma, il tracciato cefalometrico è un grande aiuto per la diagnosi in ortodonzia anche se non lo è di più rispetto alla storia clinica e all’esame clinico.
Tracciato cefalometrico: un po' di storia
La cefalometria come metodo di studio e diagnosi ha quasi un secolo. L'introduzione della cefalometria radiografica fu effettuata da B. Holly Broadbent nel 1931, ma le indagini svolte a fini antropologici iniziarono nel 1780 da Camper che descrisse l'utilità dell'angolo formato dall'intersezione di un piano disegnato dalla base del naso al canale uditivo esterno (piano Camper) con il piano tangente al profilo facciale. Nel 1884, al Congresso Internazionale di Antropologia di Francoforte, il piano che collega il bordo superiore del canale uditivo esterno con il punto più basso del bordo orbitale fu accettato come piano di orientamento standard. Gli studi antropologici effettuati sui crani potrebbero essere approfonditi, a partire dal 1895, con la scoperta dei raggi X da parte di WK Von Rontgen. Nel 1921 AJ Pacini presentò la sua tesi "Antropotemetria radiografica del cranio", in cui viene discussa per la prima volta l'utilità di questo studio, per la conoscenza della crescita umana, della sua classificazione e delle sue anomalie. Stabilì che la precisione delle misurazioni ottenute dalla radiografia superava quelle fatte dalla comune antropologia. Ha trasferito alcuni punti antropologici convenzionali alla radiografia, come il gonion, il nasion e la spina nasale anteriore. Nel 1922 Atkinsons descrisse l'utilità della teleradiografia per determinare la posizione del primo molare superiore. Nel 1926, grazie all'entusiasmo dell'Onorevole Francis P. Bolton, fu condotto lo studio della normale crescita dei denti e delle mascelle dei bambini. Poi, nel 1932, grazie alla generosità della famiglia Bolton, si poté condurre uno studio longitudinale a lungo termine della crescita cranio-facciale.